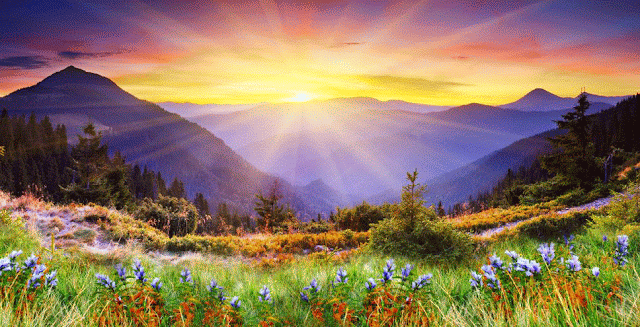1.
Hai chiesto alla nostra inutilità di dirti, padre e fratello, “se
è corretto confessare i nostri peccati ai monaci che non hanno gli
ordini sacri”, aggiungendo anche questo: “perché abbiamo sentito
che il potere di legare o sciogliere è stato dato solo ai
sacerdoti”. Queste, poi, sono parole e indagini a beneficio della
tua anima amica di Dio e del suo ardente desiderio
e
timore.
Abbiamo riconosciuto la tua buona
disposizione poiché cerchi di conoscere le cose divine e sacre, ma
abbiamo voluto rimanere in silenzio perché non siamo all’altezza
di alcuni in grado di distinguere tra queste cose e scrivere su di
loro. Il lavoro di “interpretare le cose spirituali alle persone
spirituali” (1 Cor 2, 13)
appartiene a coloro che sono liberi dalle passioni e sono santi
uomini, da cui siamo molto lontani per quanto riguarda la nostra
vita, le parole e le virtù.
2.
Tuttavia, sta scritto, “Il Signore è vicino a quelli che lo
invocano, a quanti lo invocano in verità” (Sl 144, 18). E
poiché io, indegno, l’ho domandato a Lui in verità, dirò le
seguenti cose, non per mio valore, ma per quello della divina
Scrittura divinamente ispirata. Quindi, piuttosto che insegnare, mi
limiterò a portarti la testimonianza della Scrittura, leggendoti le
cose che mi sono state richieste. Infatti, con la grazia di Dio, devo
custodire me stesso come coloro che mi ascoltano da entrambi
i precipizi, ossia,
dal precipizio di seppellire il talento (Mt 25, 18-24), e dal
precipizio d’insegnare le dottrine divine indegnamente nella
vanagloria, o meglio, nelle tenebre.
Pertanto,
dove dovremmo cominciare il nostro commento, se non dalla causa,
dall’inizio stesso di tutte le cose? Così è meglio, in modo da
essere certi di ciò che sarà detto, poiché non siamo stati creati
né da angeli né da uomini, ma dalla sapienza dell’alto, cioè
misticamente, dall’impronta dello Spirito santo. E poiché siamo
sempre stati istruiti, in ogni ora, ed abbiamo invocato la grazia,
ora parleremo prima del modo in cui si fa la confessione e poi del
suo potere.
3.
La confessione non è altro che l’ammissione dei nostri debiti e,
di conseguenza, la
profonda consapevolezza delle nostre cadute, ossia un
disprezzo della nostra povertà e stoltezza. Il Signore parlava in
parabole nei Vangeli di “... due debitori: l’uno gli doveva
cinquecento denari, l’altro cinquanta. E quando non avevano nulla
con cui ripagare, li perdonò
entrambi” (Lc 7, 41-42). Quindi ogni fedele è un debitore
davanti al suo Maestro e Dio. Tutto ciò che ognuno ha ricevuto da
Lui, lo stesso gli sarà richiesto nel pauroso e terribile tribunale,
quando tutti noi, sia re sia poveri, vi compariremo nudi e
smascherati. Ascoltate ora cosa e quanto abbiamo ricevuto da Lui.
Naturalmente, esistono molte altre cose delle quali nessuno è in
grado di farne l’enumerazione. Ma al momento presente, la migliore
e più completa è la liberazione dalla condanna,
la santificazione
dalla lordura,
l’a-vanzamento della sua ineffabile luce dalle tenebre, la
possibilità di divenire suoi seguaci, figli ed eredi attraverso il
divino battesimo e di essere vestiti di Dio stesso, per divenire sue
membra e ricevere la presenza dello Spirito santo in noi, che è un
sigillo reale utilizzato dal Signore per contrassegnare le sue
pecore. Ma cosa sto descrivendo con il “tante cose”?
Semplicemente questo: che Egli ci rende come se stesso e ci abilita a
essere suoi confratelli e coeredi. A coloro che sono stati
battezzati, sono date tutte queste cose direttamente dal battesimo,
definite dal divino Apostolo come “divine ricchezze ed eredità”
(Col 1, 12; Ef 3, 8; 2 Cor 4, 7).
4.
I comandamenti del Sovrano sono stati dati come custodia di queste
grazie e doni ineffabili e circondano tutto il credente come un muro,
creandogli un porto sicuro per il tesoro nascosto nella sua anima. [I
comandamenti] lo sostengono e lo rendono inaccessibile a tutti i
nemici e i ladri. Perciò, crediamo di poter custodire i comandamenti
di un Dio amico dell’uomo, pur essendo piuttosto consapevoli del
fatto che, provati, siamo custoditi da loro. Colui che osserva i
comandamenti di Dio non sostiene e protegge
loro quanto se stesso dai nemici visibili e invisibili, dei
quali, innumerevoli e paurosi, l’Apostolo Paolo parla dicendo: “La
nostra battaglia non è contro sangue e carne, ma contro i dominatori
di questo mondo oscuro, contro gli spiriti del male che abitano nei
luoghi alti” (Ef 6,12), in altre parole, coloro che si
trovano nell’aria e sono sempre invisibilmente schierati contro di
noi.
Pertanto,
colui che osserva i comandamenti stessi è da loro protetto e non può
perdere le ricchezze che Dio gli ha affidato. Ma colui che disprezza
i comandamenti si espone nudo ai nemici ed è facilmente sconfitto da
loro. E, dopo aver perso tutte queste ricchezze, egli è in debito
con il Re e Sovrano per tutte le cose di cui abbiamo parlato,
impossibili per l’uomo da ritornare o addirittura da trovare. Per
questo [tali cose] sono celesti ed Egli è venuto dal cielo. Così,
Egli viene ogni giorno, le porta e le distribuisce ai fedeli. Coloro
che una volta le ebbero ricevute per poi perderle, dove potrebbero
trovarle nuovamente? Veramente da nessuna parte! Proprio come né
Adamo, né alcuno dei suoi figli, è stato in grado di restaurare se
stesso o rifare i suoi, sarebbe stato impossibile non essendo Dio
sopra ogni essere, divenire figlio di Adamo secondo la carne, nostro
Signore Gesù Cristo, per innalzare lui e noi dalla nostra caduta con
la sua potenza divina. Per quanto riguarda i comandamenti, chi
sceglie di mantenere alcuni tra loro e abbandonarne altri, dev’essere
consapevole del fatto che se si trascura di mantenere anche uno dei
comandamenti, si perderanno tutte le ricchezze. Immagina che i
comandamenti siano come dodici uomini armati che ti circondano tutto
attorno, mentre tu stai nudo in piedi in mezzo a loro che stanno di
guardia. Immagina anche altri guerrieri, tuoi avversari, che vengono
e ti circondano cercando di afferrarti per ucciderti subito.
Pertanto, se uno dei dodici è tolto dalla tua scelta e trascura di
proteggerti lasciando il suo posto come una porta aperta al nemico,
che beneficio possono dare i rimanenti undici uomini se anche uno
solo dei nemici è in grado di entrare verso il centro e, senza
pietà, ti taglia a pezzi, mentre gli altri undici non possono più
circondarti per aiutarti? Infatti, anche se hanno scelto di
circondarti per aiutarti, pure loro saranno uccisi dal nemico. Quindi
la stessa cosa ti accadrà se non osservi i comandamenti. Perché in
caso di caduta per un solo colpo del tuo nemico, tutti i comandamenti
si lasciano e, poco a poco, la tua forza viene meno. O, per dirla in
un altro modo, un vaso pieno di vino o di olio non ha bisogno di
essere forato attorno per perdere tutto il suo contenuto. Un singolo
foro aperto in un posto è sufficiente perché quanto è all’interno
sia lentamente perso. Allo stesso modo, se si trascura un solo
comandamento, si cade lentamente lontano da tutti gli altri, come
Cristo disse: “Poiché chiunque ha sarà dato, ed egli sarà
nell’abbondanza. Ma a chi non ha sarà tolto quello che ha” (Mt
25, 29). E ancora: “Chiunque avrà violato uno di questi minimi
comandamenti”, e per la sua trasgressione, “colui che insegna
agli uomini a fare altrettanto sarà chiamato minimo nel regno dei
cieli” (Mt 5, 19). E Paolo disse: “Ciascuno è, infatti,
schiavo di colui che lo vince” [Questo passo fa parte di 2 Pt 2,
19]. E ancora: “Il pungiglione della morte è il peccato, e la
forza del peccato è la legge” (1 Cor 15, 56). Da nessuna
parte ha detto questo o quel peccato specifico, ma che ogni peccato è
il pungiglione della morte. Si chiama peccato il pungiglione della
morte perché chi ne viene punto muore. Per cui ogni peccato è per
la morte, perché anche se qualcuno ha peccato, fosse una sola volta,
Paolo dice che è già morto, essendo sotto accusa per il debito e il
peccato, lasciato disteso sulla strada dai ladri.
5.
Cosa, allora, fa risollevare un morto causato da qualcuno? E che fa
colui che non è in grado di pagare il suo debito e ricevere la
remissione di tale debito evitando di essere gettato in carcere fino
a che non può rimborsare, cosa che non potrà mai fare dal momento
che non ha nulla con cui pagare il suo debito e, quindi, non potrà
mai uscire dall’eterna prigione, cioè dall’oscurità eterna?
Colui che è stato ferito dai ladri spirituali chiede che un medico
compassionevole e misericordioso venga a lui. Egli non ha in sé il
timore di Dio, ossia non è abbastanza fervente da essere in grado di
andare da un medico in quanto la sua anima è debole per la
trascuratezza, e sta lì offrendo un terribile e infelice spettacolo
a coloro che sono in grado di vedere bene, vale a dire, a chi è in
grado di vedere spiritualmente le cadute dell’anima. Così,
attraverso il peccato, si diviene schiavi del diavolo: “Non sapete
che se vi fate schiavi di qualcuno obbedendogli, siete schiavi di
quello cui obbedite, sia del peccato per la morte, sia
dell’obbedienza per la giustizia?” (Rm 6, 16), ed è una
presa in giro del Padre e di Dio, il disprezzo dei nemici che
apostatano da Dio.
Così
uno diviene spoglio della porpora reale ed è lasciato annerito.
Invece di figlio di Dio, diviene figlio del diavolo. Che cosa può
fare al fine di acquisire nuovamente le cose dalle quali si
allontanò? Che altro se non chiedere un mediatore e un amico di Dio,
che ha il potere di riportarlo nella sua condizione precedente e
riconciliarlo a Dio suo Padre? Colui che è unito a Cristo con la
grazia diviene suo membro ed è da Lui adottato; se poi lo abbandona,
è come il cane che “si rivolge al suo vomito” (2 Pt 2, 22),
e si unisce ad una prostituta o ad un altro corpo, è condannato come
i miscredenti poiché ha disonorato e bestemmiato Cristo stesso.
Infatti, secondo il divino Apostolo, “voi siete corpo di Cristo, e
sue membra, ciascuno in particolare” (1 Cor 12, 27).
Pertanto, chi si unisce ad una prostituta rende le membra di Cristo
membra di fornicazione (1 Cor 6, 15). Quindi, uno che ha fatto
una cosa del genere ha fatto arrabbiare il suo Maestro e Dio e non
può essere riconciliato con Dio se non attraverso la mediazione di
un uomo che è santo, amico e servo di Cristo, astenendosi dal male.
6.
Per questo motivo, dobbiamo prima di tutto fuggire dal peccato.
Tuttavia, se accade che siamo trafitti dal dardo del peccato, non
dobbiamo attardarci e permettere che il suo veleno c’invogli come
il miele. Non dovremmo ripetere la stessa cosa come un orso che ne è
stato attratto, rendendo maggiore la ferita. Ma, piuttosto, dobbiamo
correre direttamente da un medico spirituale, purificando noi stessi
del veleno del peccato con la confessione e sputando il veleno.
Dovremmo rapidamente ricevere come antidoto l’epitimìa [la
correzione] che lui ci offre per il nostro pentimento sempre
compiendola con fede fervida e lottando nel timore di Dio. Per tutti
coloro che si sono privati delle ricchezze, si sono affidati a loro
stessi e hanno dilapidato i loro beni paterni alle prostitute e ai
pubblicani, e la cui coscienza ora è così appesantita dal peccato
da non poter più guardare verso l’alto, privi di coraggio davanti
a Dio, chiedono naturalmente un uomo di Dio che possa ricevere il
loro debito. E poi, per mezzo suo, possano avvicinarsi a Dio,
qualcosa d’impossibile da farsi senza pentimento sincero e fatiche
continue se si vuole ristabilire la propria relazione con Dio.
Infatti, non si è mai sentito parlare o è riportato nelle Scritture
divinamente ispirate che si possa prendere su sé i peccati di un
altro e difenderlo se prima il peccatore non ha intrapreso fatiche
corrispondenti ai peccati e ha mostrato adeguati frutti del suo
pentimento. Poiché, come disse la voce del Precursore della Parola:
“Fate dunque veri frutti di conversione e non v’illudete col
dire: Abbiamo Abramo per padre” (Mt 3, 8). Infatti il
Signore stesso disse a coloro che così stupidamente vivono: “In
verità, vi dico: anche se si levano in piedi tra loro Mosè e
Daniele per salvare i loro figli e le loro figlie, non saranno
salvati” (vedi LXX Ez 14, 14; 16, 20). Che dobbiamo dunque
fare, noi che desideriamo pentirci, e in che modo, per avere i nostri
debiti rimessi ed essere sollevati dalla nostra caduta? Ascoltate, se
Dio vuole, quanto posso spiegare a ciascuno di voi.
7.
Se desideri cercare un mediatore, un medico e un buon consigliere,
lascia che ti mostri come un buon consigliere applicherà il suo
consiglio sui modi di pentimento; lascia che ti mostri come un medico
darà la medicina appropriata per ogni ferita; lascia che ti mostri
come sarà un mediatore attraverso la preghiera; e come avrà
comunicazione con Dio e starà dinnanzi a Lui faccia a faccia in tuo
favore per ottenere la misericordia del Divino. Non devi cercare un
alleato o un consigliere in un adulatore o in uno schiavo del ventre
perché non vanno contro la tua volontà e non ti insegnano queste
cose gradite a Dio, ma quelle che desideri accettare e, quindi,
rimani ancora una volta nemico di Dio e non riconciliato con Lui. Non
accettare né un medico inesperto che t’immergerà nella
disperazione con la sua grande brutalità e con improprie incisioni e
cauteri, né chi, nella sua eccessiva simpatia, ti lascerà malato
mentre penserai di essere guarito e, peggio di tutto, quanto non ci
si dovrebbe aspettare!, ti consegnerà all’eterno inferno.
Perciò quest’inferno
si realizza quando, in questa vita, la malattia dell’anima,
non è guarita ma continua fino a quando non muore con noi. “Infatti,
non tutti i discendenti d’Israele sono Israele” (Rm 9, 6),
ma solo coloro col nome che conoscono pure il potere del nome e sono
intelletti che vedono Dio. Allo stesso modo, non tutti coloro che
sono chiamati cristiani sono veramente cristiani. “Non chiunque mi
dice: Signore, Signore”, Cristo dice, “entrerà nel regno dei
cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”. E
aggiunge che “molti mi diranno in quel giorno [...] nel tuo nome
abbiamo cacciato demoni [...] allora dichiarerò loro: Non vi ho mai
conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità” (Mt
7, 21-23).
8.
Questo è il motivo per cui, fratelli miei, tutti noi dobbiamo stare
attenti — i mediatori, da un lato e i peccatori dall’altra che
desiderano essere riconciliati con Dio — affinché né i mediatori
facciano scendere l’ira sulle loro teste invece di aver ricompense,
né i peccatori che desiderano essere riconciliati con Dio abbiano un
nemico, un assassino e un cattivo consigliere, invece di un vero e
proprio mediatore. Per costoro c’è il re che proferirà parole
terribili: “Chi ti ha reso capo e giudice sul mio popolo?” (cfr.
Es 2, 14)? E ancora: “Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio
del tuo fratello” (Mt 7, 5). Infatti il legno è una
passione o un desiderio che scurisce l’occhio dell’anima. E
inoltre: “Medico, cura te stesso” (Lc 4, 23) e ancora: “Ma
al peccatore Dio ha detto: Perché tu racconti i miei decreti e
ripeti la mia alleanza con la tua bocca? Tu hai odiato la disciplina
e hai gettato le mie parole dietro alle spalle” (Sl 49, 16)?
E Paolo dice: “Chi sei tu che giudichi un servo altrui? Stia in
piedi o cada ciò riguarda il suo padrone” (Rm 14, 4).
9.
Pertanto, a causa di tutte queste cose, fratelli e padri miei, mi
vengono i brividi e tremo. Chiedo a tutti voi, anche con questa
esortazione a voi da me rivolta, di non essere superficiali su questi
misteri divini, venerati da tutti, non giocate con cose che non sono
giochi, e non agite contro la vostra anima a causa di vanagloria,
ambizione, o per lucro o per insensibilità. Infatti, è possibile
assumere perfino uno strano ragionamento solo per il fatto di essere
chiamati “padri” o “maestri”. Vi prego, poiché stiamo
semplicemente insegnando con l’esempio
terreno,
cerchiamo di non usurpare spudoratamente un onore uguale agli
apostoli. Poiché
se qualcuno spudoratamente osa assumere la mansione del re terreno e
viene sorpreso, assieme ai suoi ministri e seguaci, a espletare in
segreto o in modo manifesto ciò che al re competeva, costui è
sottoposto a estremi castighi allo scopo d’intimorire gli altri
[eventuali usurpatori], e [quindi] tutti lo deridono in quanto egli è
stolto e dissennato.
Che sorte, allora, avranno coloro che si appropriano indegnamente
dell’ufficio di apostoli?
10.
Né dovresti desiderare di divenire mediatore per altri prima di
essere stato riempito di Spirito santo, di conoscere, ed essere
riconciliato con il Re di tutto e percepirlo nella tua anima. Perciò
nessuno che conosca il re terreno può essere un mediatore davanti a
lui al posto di altri. Estremamente pochi sono in grado di fare ciò,
poiché hanno acquisito tale familiarità davanti a lui e per le loro
virtù, il loro sudore e le fatiche effuse per lui. Costoro non hanno
bisogno di un mediatore tra lui e loro stessi, ma conversano bocca a
bocca con il re. Pertanto, padri e fratelli, non dovremo mantenere lo
stesso ordine davanti a Dio? Non onoriamo il Re celeste almeno
altrettanto come il re terreno? Abbiamo intenzione di usurpare e
concederci di sedere alla sua destra e alla sua sinistra prima ancora
di chiederlo e riceverlo? Che incoscienza! Che cosa vergognosa si è
impadronita di noi? Perché, anche se siamo chiamati a rendere conto
di nient’altro che questo, ossia di essere sprezzanti, saremo
caduti in disgrazia e ci verrà negato un posto di dignità e saremo
gettati nel fuoco eterno. Ora, ciò che è stato detto è sufficiente
per esortare coloro che vogliono essere attenti a loro stessi. Per
questi motivi, le nostre parole hanno divagato un po’ oltre il
soggetto a nostra portata. Ma ora, figlio mio, dovremo affrontare
quanto mi hai chiesto di conoscere.
11.
Tu troverai che la confessione ad un monaco, che non ha ordini sacri,
è stata praticata in tutto il mondo sin da quando i monaci esistono
poiché la veste del pentimento e la vita monastica sono state date
da Dio in sua eredità, come si riporta negli scritti divinamente
ispirati dei Padri. E, se si guarda a loro, troverai che quello che
stiamo dicendo è vero. Prima di ciò, come successori dei santi
apostoli, solo i vescovi hanno ricevuto
il potere di legare e sciogliere. Ma, con il passare del tempo, i
vescovi si sono corrotti, e questo tremendo incarico è stato
trasmesso ai sacerdoti che avevano una vita irreprensibile ed erano
degni della grazia. Più tardi, pure i sacerdoti, associandosi ai
vescovi, sono divenuti proprio come il resto della popolazione. E
molti di loro, proprio come ora, sono caduti nello spirito
dell’illusione, del discorso vano e vuoto e si sono persi. Quindi,
il potere di legare e sciogliere è stato trasferito ai prescelti,
tra il popolo di Dio, vale a dire ai monaci. Non è che questo potere
sia stato rimosso dai preti e dai vescovi, ma i sacerdoti e i vescovi
si sono estraniati da tale grazia. “Infatti, ogni sommo sacerdote,
preso tra gli uomini, è costituito in favore degli uomini nelle cose
che riguardano Dio”, come dice l’apostolo Paolo, aggiungendo “e
deve offrire sacrificio per i peccati, come per il popolo, anche per
se stesso” (Ebr 5, 1, 3).
12.
Ma andiamo avanti e iniziamo questo commento dall’inizio per vedere
quando, come e a chi è stato dato questo potere di servizio
sacerdotale di legare e sciogliere. L’ordine con cui hai formulato
la domanda renderà chiara la risposta non solo a te ma a tutti gli
altri uomini. Quando il nostro Signore e Salvatore dice all’uomo
con la mano inaridita: “I tuoi peccati ti sono perdonati”, udito
questo, gli ebrei esclamarono: “Quest’uomo dice bestemmie. Chi
può rimettere i peccati se non Dio solo?” (cfr.
Mt 9, 2-3; Mc 2, 7; Lc 5, 21). Infatti il perdono [ex officio]
dei peccati non è mai stato dato da profeti o sacerdoti o da uno dei
patriarchi di quei tempi. Questo è il motivo per cui gli scribi
hanno respinto le parole di Cristo come una nuova dottrina o
predicazione bizzarra. Ecco perché il Signore non li biasima per
ciò, ma insegna loro qualcosa che non sapevano, mostrandosi come
garante della remissione dei peccati come Dio, non come uomo. Egli
aggiunge loro: “Ora, affinché sappiate che il Figlio dell’uomo
ha il potere sulla terra di rimettere i peccati” (Mt 9, 6),
dicendo all’uomo con la mano inaridita: “Stendi la tua mano. Ed
egli la stese e tornò sana come l’altra” (Mt 12, 13).
Così mediante un miracolo visibile ne ha mostrato un altro maggiore
e invisibile. Successe lo stesso con Zaccheo, lo stesso con Pietro
che lo rinnegò tre volte, lo stesso con il paralitico che Egli guarì
e poi trovatolo disse: “Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché
non ti accada qualcosa di peggio” (Gv 5, 14). Dicendo
questo, mostrò che l’uomo si era ammalato a causa del peccato e,
quando è stato guarito dalla malattia, ha ricevuto la remissione dei
suoi peccati, senza digiuno, senza rendere il suo letto come una dura
terra, attraverso la sua conversione, la sua fede senza esitazioni,
la cesura dal male e attraverso il vero pentimento e molte lacrime,
come la prostituta e come Pietro che pianse amaramente.
Da
tale principio deriva il grande dono che appartiene a Dio solo, e che
solo lui possiede. Quando stava per ascendere al cielo, al suo posto,
ha poi lasciato tale dono ai suoi discepoli. Com’è possibile che
ha dato quest’autorità e potere a loro? Vediamo a chi, a quanti e
quando. Ai suoi scelti undici discepoli, quando passò attraverso le
porte chiuse ed essi erano raccolti all’interno. Entrò, stette in
mezzo e soffiò su di loro dicendo: “Ricevete lo Spirito santo; a
chi rimetterete i peccati, sono loro rimessi; a chi li ritenete, sono
ritenuti” (Gv 20, 22-23). Non diede loro alcun comando per
quanto riguarda l’epitimìa poiché sarebbe stata loro
insegnata dallo Spirito santo (cfr.
Gv 14, 26).
13.
Così, come abbiamo detto, [tale dono] dai santi apostoli passò a
coloro che succedettero loro. Costoro salirono sui loro troni, in
modo che tra gli altri nessuno potesse nemmeno avere il coraggio di
pensare a qualcosa di simile. E così i discepoli del Signore
custodirono l’autorità di questo potere con grande cura. Ma, come
abbiamo detto precedentemente, con il passare del tempo, i degni si
mescolarono con gli indegni. E poiché gli indegni erano molti di
più, hanno oscurato e corrotto i degni impegnandoli in dispute su
chi avesse maggiore autorità e finta virtù per presiedere sugli
altri. E poiché coloro che sedevano sui troni degli apostoli si
mostrarono carnali, amanti del piacere e appassionati agli onori, si
sono inclinati verso le eresie. La grazia divina ha abbandonato
uomini come questi e il potere è stato loro rimosso. È per tale
motivo che tutte le qualità che dovrebbero possedere gli operatori
del servizio sacerdotale sono poste in disparte e l’unica cosa loro
richiesta per essere ordinati è quella d’essere ortodossi. Così,
a coloro che dovevano essere ordinati fu chiesto solo questo.
Tuttavia, temo che in realtà non dovrebbero nemmeno chiedere ciò.
Infatti, uno non è ortodosso solo perché non porta una nuova
dottrina nella Chiesa di Dio, ma perché ha una vita che è coerente
con il corretto insegnamento. Diversi patriarchi e metropoliti, hanno
a volte cercato questo tipo di candidato, entrambi con insuccesso, o
hanno preferito gli indegni a costui. E dall’indegno ebbero bisogno
solo di una dichiarazione firmata sul Simbolo di fede. Gli hanno
chiesto solo ciò: che non sia un fanatico per il bene, né che lotti
contro qualcosa di male. Presumibilmente, stavano collaborando alla
pace della Chiesa in questo modo, ma questo modo è peggiore di
qualsiasi odio ed è causa di un gran disordine. Per tale motivo i
sacerdoti si sono corrotti e sono divenuti come il popolo. Per cui
tra loro non ci fu nessuno che fosse il sale di cui e su cui ha
parlato il Signore e che, utilizzando rimproveri, potesse bloccare e
controllare la dispersione della vita. Al contrario, si sono
accordati e hanno coperto le cattive passioni l’uno all’altro,
divenendo peggio del popolo. E il popolo, a sua volta, è divenuto
peggio di loro. In effetti, alcune delle persone hanno dimostrato
d’essere meglio dei preti perché, in mezzo al buio totale dei
sacerdoti, sono apparsi come un carbone acceso. Infatti, secondo le
parole del Signore, se nella loro vita i preti si fossero disposti a
“risplendere come il sole” (cfr. Mt 5, 16; 13, 43), la
brace non sarebbe stata vista brillare e sarebbe apparsa oscura
rispetto alla luce più potente. Ma poiché tra la gente del posto è
rimasta solo la forma e l’aspetto esterno del sacerdozio, il dono
dello Spirito santo è stato trasferito ai monaci. Fu riconosciuto
dai segni che lo dimostrano che i monaci, con le loro opere, vivevano
la vita degli apostoli. Anche lì, poi, il diavolo ha nuovamente
eseguito il suo lavoro: vedendo che i monaci sono apparsi nel mondo
come alcuni nuovi discepoli di Cristo e splendevano per la vita e i
miracoli, ha recato tra loro, mescolando di mezzo a loro, dei falsi
fratelli, suoi contenitori. Costoro lentamente aumentarono, come si
vede, e i monaci si corruppero divenendo monaci completamente
amonastici. E quando videro che erano inutili, non divennero meglio
di coloro che avevano lo schema monastico o di quanti erano chiamati
sacerdoti o di coloro che avevano assunto l’onore episcopale ossia
i patriarchi, i metropoliti e i vescovi.
14.
Pertanto, il potere di rimettere i peccati non è dato da Dio né a
coloro che hanno lo schema monastico né a coloro che sono ordinati
nei ranghi del sacerdozio, né
a quelli
onorati dall’ufficio dell’episcopato, voglio dire ai
patriarchi e metropoliti e vescovi, solo a causa della loro
ordinazione e della loro sede. Il cielo non lo voglia! È loro
autorizzata solo l’esecuzione dei servizi e, per la maggior parte
di loro ho il sospetto che non sia autorizzata neppure quella
in modo che, essendo paglia, non sia bruciata. Invece, il potere di
rimettere i peccati è dato solo a coloro tra preti e vescovi
e monaci che appartengono al rango dei discepoli di Cristo, a causa
della purezza.
15.
Come, allora, saranno quelli di cui abbiamo parlato, per sapere se
sono tra tali discepoli, e in che modo saranno gli altri che cercano
di riconoscerli precisamente dopo di loro? A tal fine, il Signore ci
ha dato un insegnamento dicendo: “E questi segni accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni; parleranno
lingue nuove” (si riferisce alla dottrina divina e benefica della
Parola); “cammineranno sui serpenti e se bevono qualsiasi cosa
mortale, non farà loro del male” (Mc 16, 17). E anche, “le
mie pecore ascoltano la mia voce” (Gv 10, 27), e “li
riconoscerete dai loro frutti” (Mt 7, 16). Quali frutti?
Paolo enumera molti frutti e dice: “Il frutto dello Spirito invece
è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, temperanza” (Gal 5, 22), e quelli che li
accompagnano sono “compassione, fraterno amore, carità”, con le
conseguenze di questi. Con loro ci sono “la parola di saggezza,
parola di conoscenza, il dono della guarigione” e molto altro. “Ma
tutte queste cose le opera quell’uno e medesimo Spirito, donando a
ciascuno come vuole” (1 Cor 12, 8-11). Quindi quelli che
sono divenuti i partecipanti a tali doni – in tutto o in parte in
base a ciò che è loro vantaggioso – sono contati nel coro degli
apostoli. Annoverati pure tra loro ci sono quelli che oggi diventano
come loro. Ed è per questo che essi sono la luce del mondo, come
dice Cristo stesso: Nessun uomo che accende una candela la pone sotto
un tavolo o sotto il letto, ma su un candeliere in modo che darà
luce a tutti quelli che sono nella casa (cfr.
Mt 5, 14, 15). Essi sono noti non solo per questo, ma per la
condotta della loro vita. Perciò in questo modo coloro che cercano
tali uomini, così come gli uomini stessi, possono sapere se, a
somiglianza del Signore nostro Gesù Cristo, essi non siano causa di
vergogna e, come lui, abbiano, al contrario, accettato con più
grande gloria e umiltà e obbedienza priva d’ipocrisia i
loro padri e guide e, inoltre, le loro guide spirituali; se,
con tutta la loro anima, abbiano amato il disonore, gli insulti, il
ridicolo e i rimproveri; se abbiano considerato chi loro porta tali
cose come causa di grandi doni e abbiano pregato in lacrime per loro
con tutta la loro anima; e se abbiano sputato alla gloria di questo
mondo e considerato letame le delizie di questo stesso mondo.
Ma
devo dire tanto e dire l’ovvio, allungando il mio commento? Se un
uomo trova che ha raggiunto ogni virtù sentita dalla lettura della
Sacra Scrittura e si è esercitato in ogni opera buona e conosce il
grado del suo avanzamento e del cambiamento, per quanto riguarda
ciascuna di esse, sta salendo alle vette della gloria divina,
facendolo quindi partecipare a Dio e ai suoi doni; e coloro che lo
vedono chiaramente, come quelli con una visione più debole, lo
riconosceranno. Coloro che sono come lui possono dire a tutti con
coraggio: “Noi siamo ambasciatori per Cristo, come se Dio
supplicasse attraverso di noi [...] siate riconciliati con Dio” (2
Cor 5, 20). E tutti coloro che sono come costoro, hanno mantenuto
i comandamenti di Dio fino alla morte. Hanno venduto i loro beni e
distribuito i soldi ai poveri. Hanno seguito Cristo e subìto le
tentazioni. Hanno perso la vita in questo mondo, per amore di Dio e
la ritrovano nella vita eterna. E quando hanno ritrovato la loro
vita, sono stati visti in una luce noetica. E poi in questa luce
hanno visto la luce inaccessibile, [che è] Dio stesso, com’è
scritto: “Nella tua luce vedremo la luce” (Sl 35, 10). Ma
com’è possibile per uno trovare la vita che ha già? Fa’ molta
attenzione! La vita di ogni uomo è una dramma che abbiamo perso
(cfr. Lc 15, 8-10). Per cui non è Dio, ma è ognuno di noi ad
essersi immerso nelle tenebre del peccato. Ma Cristo, la luce vera,
viene e incontra faccia a faccia coloro che lo cercano garantendo che
possono vederlo mediante i mezzi che Lui solo conosce. Questo è ciò
che significa per uno trovare la sua vita: vedere Dio e in quella
luce divenire più alto di tutti nella creazione visibile e avere Dio
come suo pastore e maestro dal quale, se lo desidera, imparerà a
legare e a sciogliere. E dopo averlo appreso con precisione, adora
Dio che gli ha dato tale dono e lo trasmetterà a tutti coloro che ne
hanno bisogno.
16.
Vidi che a questi uomini, figlio mio, è dato <il potere> di
legare e sciogliere da Dio Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo,
per mezzo dello Spirito santo. Essi sono tra i suoi figli adottivi e
servitori sacri. Io ero discepolo di un tale padre, che non ha avuto
l’ordinazione da uomini ma mi ha fatto discepolo per la mano di
Dio, ossia per lo Spirito santo. Egli mi ha ordinato di ricevere
l’ordinazione dagli uomini, poiché era bene osservare la forma
consueta in quanto, dai miei primi giorni, lo Spirito santo mi stava
muovendo verso di essa con un grande desiderio.
17.
Pertanto,
miei fratelli e padri, preghiamo
principalmente
di
divenire come loro, in grado di parlare agli altri della libertà
dalle passioni e di sentire i loro pensieri. Cerchiamo un padre
spirituale. Infatti, ricerchiamo accuratamente per trovare tali
uomini, veri discepoli di Cristo. E supplichiamo Dio con doglie del
cuore e molte lacrime per molti giorni per aprire gli occhi del
nostro cuore affinché possiamo conoscere se e dove un tale uomo è
da ricercarsi tra la nostra malvagia generazione. E, dopo averlo
trovato, preghiamo affinché possiamo ricevere la remissione dei
peccati per suo mezzo, obbedendo ai suoi comandi ed esortazioni con tutta l’anima, proprio come lui obbedisce ai comandamenti di
Cristo, ed è divenuto partecipante alla sua grazia e ai doni da Lui
ricevuti; il potere di legare e sciogliere i peccati è dato dal
fuoco dello Spirito santo, al quale sia ogni gloria, onore, e
adorazione assieme al Padre e al Figlio unigenito nei secoli. Amìn.
©
Chiaranz Pietro